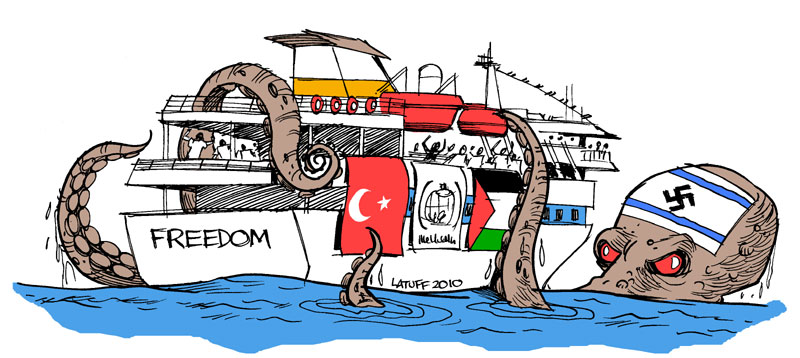I rifugiati dell’ex-ambasciata somala e il sogno negato di una vita migliore
Elisabetta Viozzi
Via dei Villini a Roma. Ci sono malati nelle stanze luride, gelide. Ma rimangono solidali: il cancello in ferro battuto è sempre aperto, per chi ha bisogno, nonostante non ci sia più spazio neanche per un altro, povero, materasso di gomma piuma.

Siamo quasi al centro di Roma. Da un lato c’è la gloriosa Porta Pia e dall’altro la meno eroica ma ugualmente centrale, nella storia patria, Villa Torlonia. Nel mezzo, tra sedi diplomatiche, residenze dell’alta borghesia e palazzi liberty c’è Via dei Villini. Già altri, da queste pagine, hanno scritto e denunciato l’orrore che non ti aspetti da quelle parti. Un orrore che, paradosso vuole, si trova esattamente in quello che fu uno splendido villino dei primi del 900, ex-sede dell’ambasciata della Somalia. Avevo letto ed ero rimasta inorridita alle descrizioni di cosa c’è dietro quel cancello. Ma non ero comunque preparata all’impatto con la realtà. Evito quindi di ripetere la descrizione dell’antico splendore decaduto, delle mura fatiscenti, dei cumuli d’immondizia, dei giacigli improvvisati ammassati l’uno sull’altro. Mi vorrei occupare degli abitanti di quello squallore. Il primo che incontro è Garmeelatl, spero di riportare correttamente lo spelling, che mi racconta un po’ la loro storia. Sono più di 150 somali là dentro, nello sporco, con il pericolo che qualcosa crolli, mi dice. Si sentono soli, nessuno li aiuta.
Ci sono malati nelle stanze luride, gelide, per lo più senza infissi. Qualcuno ha preferito vivere per strada, mi racconta. Ma quando mi dice che è lì da solo 6 mesi, perché prima era in Nord Europa, gli occhi gli si illuminano, alza la voce, gli altri gli si fanno intorno. Sì perché se possibile, la sua, la loro situazione è resa peggiore da un fatto: hanno un termine di paragone sul trattamento che uno stato può riservare a quelli come loro. Tira fuori il portafogli ed, in breve, mi circondano le mani tese di questi ragazzi, che mi mostrano badge, carte di credito, tessere. Lingue diverse su ognuno, ma lo stesso concetto: in Svezia, Norvegia, Olanda, Germania lo stato provvedeva, dando loro un mensile fisso accreditato su un conto personale, l’assistenza sociale, l’insegnamento della lingua. Miracoli dell’ormai mitico welfare scandinavo? Non proprio.
Questi ragazzi sono tutti rifugiati o titolari di protezione umanitaria: status riconosciuto loro dall’Italia. Sono scappati dal loro paese perché lì la loro vita era a rischio: il nostro paese non ha fatto un mero gesto umanitario, accogliendoli. Si è, molto banalmente, dovuta attenere ad uno degli obblighi più antichi del diritto internazionale: il dovere di dare rifugio a chi fugge dalla persecuzione, dalla discriminazione, dalla guerra. Ma se, negli altri paesi, la protezione è effettiva, garantendo anche la possibilità di riprendere in mano la loro vita, qui protezione significa un foglio in tasca e una pacca sulle spalle: poi c’è solo un’ambasciata abbandonata, o la panchina di un parco, o gli androni di una stazione di periferia. Siamo tutti giovani, mi dice Garmeelatl, guardandosi intorno.
Abbiamo la voglia e la capacità di lavorare. Ma non possiamo, qui ci ammaliamo e non riusciamo neanche ad imparare l’italiano. Gli dico che esistono scuole d’italiano per stranieri gratuite ed aperte a tutti. Mi guarda come se venissi da Marte. La nostra giornata trascorre da un autobus all’altro, da una mensa all’altra. Non abbiamo tempo di andare a scuola; dobbiamo procurarci il cibo. E poi come fare a studiare, in questo luogo? Mi indica un ragazzo dagli occhi spauriti: “Ecco vedi lui ha 17 anni”. Ci parlo, con questo ragazzo: è in Italia dal 2009, è arrivato a Crotone e ha trascorso 4 mesi nel centro di accoglienza. Ha ricevuto la protezione sussidiaria, fingendosi maggiorenne, poi è andato in Svezia, ad inseguire il sogno di una vita migliore. Sogno peraltro quasi realizzato, mi racconta, ripetendo la descrizione di un mondo felice, dove non si deve pensare a come riempire lo stomaco né a trovare una coperta per le notti fredde, ma dove si può studiare ed iniziare ad integrarsi.
Ma poi arriva, come una mannaia, la Convenzione di Dublino, che impone allo stato di prima accoglienza la responsabilità di proteggere i rifugiati. E questa è la storia di tutti: la loro sfortuna è aver visto l’Europa, per la prima volta, dai nostri confini. Gli altri paesi non possono far altro che rispedirli indietro. Una cosa mi inizia ad essere chiara, mentre attraverso quelle stanze sudice e parlo con altri ragazzi somali: qui la dignità viene prima di ogni cosa. C’è il ragazzo che fa bollire l’acqua per la pasta su di un fuoco alimentato con schizzi di alcool, mentre a pochi centimetri c’è una moquette dall’aria molto infiammabile. Il senso dell’umorismo non l’ha abbandonato: “non l’avrei mai detto di dover fare una cosa del genere, ma ci si adatta.” E ci si adatta a farsi la doccia con secchi di acqua gelida in terrazzo, ci si adatta a vivere senza servizi igienici, ci si adatta ad adibire il vecchio, cadente garage dell’ambasciata a dormitorio. Ma tutti son puliti, perfettamente in ordine, con il sorriso pronto, felici che, finalmente, qualcuno è arrivato a documentare questo inferno. Non chiedono carità, chiedono il dovuto, una chance come mi ha detto Abdi Rahim, quell’opportunità di vita che altrove hanno avuto e qui gli viene negata.
Ma rimagono solidali: il cancello in ferro battuto è sempre aperto, per chi ha bisogno, nonostante non ci sia più spazio neanche per un altro, povero, materasso di gomma piuma. E un’immagine mi ha colpito: sulla balaustra del terrazzo i piccioni mangiavano le molliche lasciate lì da qualcuno di loro. Insomma, in quell’inferno di fame e miseria, il cibo viene diviso anche con questi altri abitanti metropolitani. C’è chi li prende in giro, tra gli altri immigrati, quando li vedono scendere alla fermata del bus di Via Nomentana. Come fanno a star male, se vivono in una zona così ricca, chiedono loro.
Fonte: Articolo21
IL SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO DI RAINEWS24: ITALICA ACCOGLIENZA
21 dicembre 2010