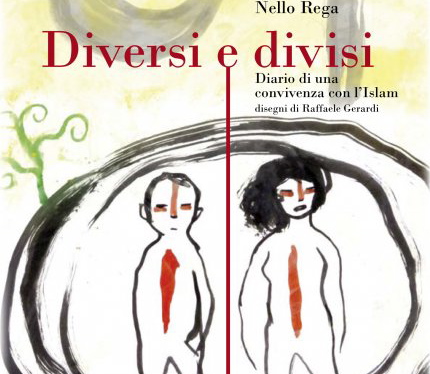Gerusalemme: La terza intifada
Paola Caridi - invisiblearabs.com
Ci sarà? Non ci sarà? I segnali ci sono tutti, la rabbia, l’assenza di speranza. Ma c’è anche il programma e la leadership?

Sassi, ragazzi e kefiah. Gli ingredienti ci sono tutti. La terza intifada può cominciare. E i segnali ci sono da parecchio tempo. Arrivati alla superficie quando, da Gaza controllata da Hamas, sono rimbalzate nella Cisgiordania di Abu Mazen immagini di guerra. Le macerie delle case distrutte dai missili israeliani, i feriti portati a braccio come sacchi, i bambini uccisi avvolti nelle bandiere di Hamas o di Fatah.
Allora la rabbia è montata. Allora i ragazzi, sì, ancora una volta i ragazzi, sono scesi per strada. Leggeri, felpa, jeans, gel sui capelli e kefiah poggiata attorno a un sorriso da adolescenti. Pronti a sfidare i soldati di Tsahal. A Hebron, a Ramallah, a Betlemme. Persino a Gerusalemme, a due passi dalla porta di Damasco. Uguali i comportamenti, ormai codificati da decenni: i sassi a terra, il fumo acre dei copertoni o dei cassonetti bruciati, i ragazzi in attesa. Poi gli slogan, e Allah u akbar. Un fischio. E parte la sassaiola. Pietre lanciate lontano, il più lontano possibile. Verso i soldati in assetto antisommossa e le loro camionette. Sfidano gli israeliani senza paura. Rischiando lacrimogeni, pallottole o, se va meglio, l’arresto. Magari a soli quindici anni d’età.
Niente armi, per ora, nelle mani dei ragazzi che non sono andati a scuola, alle superiori o all’università, per protestare davanti alla chiesa della Natività o nei campi profughi. Ma le pietre usate da padri e fratelli maggiori vent’anni fa. È solo rabbia per Gaza, soltanto un fuoco di paglia che si estingue in pochi giorni, o c’è qualcos’altro che cova sotto la cenere della Cisgiordania?
Che ci sia aria da terza intifada, lo si dice da prima dell’ultima incursione israeliana a Gaza. La Cisgiordania di Abu Mazen e del premier Salam Fayyad non è né pacificata né normalizzata. Le manifestazioni sono vietate dallo scorso giugno, da quando Hamas prese il potere nella Striscia. Gli arresti politici sono diventati pratica comune. Le accuse di torture nei confronti di chi passa negli uffici del mukhabarat, dei servizi d’intelligence, sono tante. E forse hanno trovato la loro prima vittima in un imam di Hamas, morto dopo alcuni giorni di prigionia a Ramallah. Poi a nord, tra Nablus e Jenin, il coprifuoco è una pratica ricorrente, perché quello è il laboratorio dove le forze di sicurezza addestrate sotto la supervisione del generale americano Keith Dayton devono dimostrare che si può riportare “legge & ordine” tra le fazioni palestinesi. Mentre l’esercito israeliano continua ogni giorno le retate contro i miliziani.
Ma è soprattutto la frustrazione, la mancanza di qualsiasi speranza verso una soluzione pacifica con gli israeliani a rendere la Cisgiordania un animale ferito. Da Annapolis, sul campo, non è cambiato niente: le costruzioni nelle colonie continuano, i cinquecento checkpoint non sono diminuiti, e solo un infimo numero degli undicimila palestinesi detenuti nelle carceri israeliane è uscito. Risultato: il governo di Ramallah si indebolisce. I commenti all’ordine di Abu Mazen non sono teneri, e ancor più duri sono i giudizi verso chi sta attorno al presidente. Volano accuse di collaborazionismo, corruzione, e di attaccamento alla poltrona. E gli uomini dell’ANP sono consapevoli del malcontento crescente, come dimostra il commento stanco di Saeb Erekat, negoziatore da sempre: “le trattative di pace sono state sepolte sotto le macerie delle case di Gaza”.
“Si sente l’odore della rivolta. Ma soprattutto contro gli israeliani”, dice un ex ragazzo che tirava pietre durante quella che i palestinesi chiamano intifada al oula, la “prima”. “La gente è stanca, dopo due anni di grandi, continue difficoltà economiche. Senza soluzioni all’orizzonte. È vero, quello di questi giorni può essere un movimento spontaneo, senza capi riconosciuti che guidano i ragazzi. Ma non mi stupirei se entro due mesi emergesse una leadership più giovane”.
Come esattamente vent’anni fa, insomma. Quando l’OLP era all’estero, e a tirar pietre si formarono i leader dell’interno. Marwan Barghouthi in testa. Il parallelo lo fa un altro Barghouthi, Mustafa, anche lui protagonista di quella stagione. “Sta crescendo un movimento pacifico, non violento. Al 100% popolare. E’ la gente, insomma, che sta davanti alle fazioni, non viceversa. E ricrea un movimento di liberazione nazionale”. E’ la rivolta, dice l’ex mediatore del breve governo di unità nazionale tra Hamas e Fatah, che nasce da “uno stato di apartheid, dai bantustan in cui Israele ha diviso la Cisgiordania”.
Aleggia una evidente vena di romanticismo, di nostalgia per i bei tempi andati, nel richiamo alla prima intifada. Quella più eroica. Ma non c’è bisogno di riandare col pensiero a vent’anni fa. È la seconda intifada, quella di Al Aqsa, quella delle armi, che non è mai finita. “Va e viene, come un onda. Da quasi otto anni”, commenta con una vena di tristezza Sahar Khalifah da Amman. La più grande scrittrice palestinese vivente, l’autrice del commovente Primavera di Fuoco, appena uscito in Italia. In cui ha ridato vita, amori, sogni a quella generazione di ragazzi, poco più che bambini, della seconda intifada. Una generazione perduta. “Sono loro che hanno pagato il prezzo più caro. La questione non è la numerazione delle intifade. Prima, seconda, terza, quarta. Quello che sogno è solo liberarmi da questa occupazione, e arrivare a una soluzione pacifica”. Che nessuno, però, considera possibile. Tanto meno alla fine del 2008. Semmai, è la vulgata popolare, entro la fine dell’anno qualcosa succederà. Ma non sarà una firma sotto un accordo di pace, magari sul prato della Casa Bianca.
Che le sassaiole e gli attacchi con le molotov, in aumento esponenziale negli ultimi mesi, possano essere comunque il germoglio di una intifada è, forse, l’auspicio di chi ha nostalgia di un colpo di reni. “Per avere un’intifada ci deve essere un programma e una leadership. Qui, per ora, c’è solo gente frustrata e rabbiosa”, dice Mahdi Abdul Hadi, uno degli intellettuali palestinesi più acuti, liquidando l’enfasi come una pia illusione.
Ma se ha ragione Abdul Hadi, se è vero che c’è bisogno di un programma, qualcuno che lo ha definito c’è già. E non a Ramallah, bensì a Gaza City. Dove per la terza intifada è stata individuata anche una data di nascita. Il 23 gennaio, quando gli uomini di Hamas hanno fatto saltare il muro di Rafah. Facendo tracimare in Egitto, assieme a quasi 700mila palestinesi, anche il problema politico di Gaza. Poi c’è stata la catena umana con cui donne e bambini hanno simbolicamente unito sud a nord, Rafah e Beit Hanoun. E altro ci sarà, “in gran parte pacifico”, come spiega Ahmed Youssef, il consulente più stretto di Ismail Haniyeh, che preannuncia una settimana di azioni nonviolente per l’anniversario della Nakba, della “catastrofe” del 1948, a metà maggio. Da mettere in parallelo ai Qassam sulle città israeliane di confine. “Perché – precisa – è l’unica arma che abbiamo. E speriamo che così gli israeliani si rivoltino contro i loro generali”.
Hamas, dunque, non segue la rivolta spontanea, come fu nel 1987, quando nacque come costola dei Fratelli musulmani sotto la spinta dell’intifada. Semmai, stavolta la canalizza. Tutto molto diverso dalle sassaiole della Cisgiordania. “No, non c’è niente di spontaneo. Ci sono altre associazioni, altri gruppi che organizzano”, commenta seccamente Ahmed Youssef. Che ci sia Hamas anche in Cisgiordania, dietro le proteste? Difficile semplificare in questo modo la stanchezza della gente di Hebron e Nablus, di Betlemme e persino di Ramallah. Gli studenti non avevano anzi bandiere, quando sono scesi in piazza. Nonostante qualcuno della vecchia guardia avesse tentato di metterci il proprio marchio.
Hamas, Fatah, Fronte popolare, tutti insieme. Almeno nelle proteste nei ragazzi. Che hanno incarnato quello che i sondaggi – come l’ultimo uscito dall’università di Bir Zeit – sostengono. Che i palestinesi sono stanchi non solo dell’occupazione israeliana, ma anche delle divisioni tra le fazioni. E soprattutto tra l’autorità di Hamas e l’Autorità di Abu Mazen. A farne le spese, soprattutto Fatah. Il consenso è in discesa, perché ancora una volta l’uomo della strada schiaccia Fatah sull’Autorità Nazionale, sul governo. Il partito che fu di Yasser Arafat diventa, così, il bersaglio di quello che succede in Cisgiordania. E di quello che non si riesce a ottenere dagli israeliani.
Il disagio è evidente, tra chi dentro Fatah è più legato alla base. Quando è morto sheykh Majid Barghouthi, mentre era sotto interrogatorio dell’intelligence palestinese, c’erano tutti ai suoi funerali, nel piccolo paese di Kobar, sulle colline attorno a Ramallah. L’accusa, su cui ancora indaga una commissione parlamentare d’inchiesta, è che sheykh Majid, l’imam del paese, sia stato torturato. E nel paese di Marwan Barghouthi, sono scesi tutti per seppellire il corpo dell’imam di Hamas. Seguaci di Hamas e seguaci di Fatah. Migliaia di uomini arrabbiati contro l’Autorità Nazionale. E leader di base di Fatah altrettanto stufi dell’andazzo.
“La situazione nel partito è veramente brutta”, accusa Muqbal Barghouthi, il fratello di Marwan, che ha mediato con l’intelligence il rilascio degli altri esponenti di Hamas del suo piccolo paese. Sullo sfondo, il fantasma del sesto congresso di Fatah, che sta spaccando il partito in mille rivoli. E sta facendo montare l’opposizione contro la vecchia nomenklatura. “Vogliono riprodurre la stessa malattia”, dice seccato Qaddura Fares, uno di quelli che dentro Fatah ci è entrato a sedici anni, quando era ancora clandestina. E che rappresenta coloro che hanno fatto il successo di Fatah senza avere ora voce o vero potere: la generazione dei sindacalisti, dei prigionieri, delle università. Dell’intifada, appunto. Stop ai negoziati, resistenza agli israeliani come priorità del programma. “Il 95% di Fatah condivide le mie idee, ma sta con la bocca chiusa”. Per quanto ancora? Chissà. Forse, sembra di capire, il tempo necessario per lo scoppio di un’altra intifada.
Il reportage completo sull'Espresso.
Fonte: Lettera22