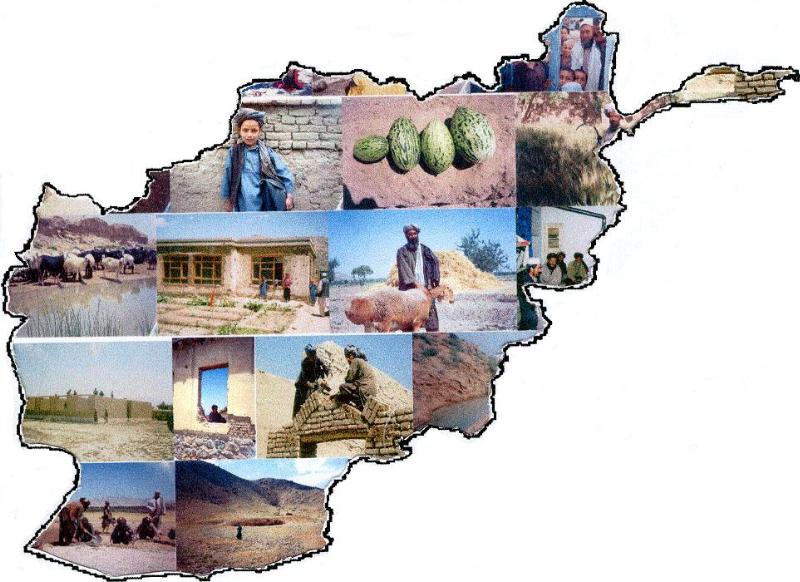Alle radici del razzismo in Italia
Giovanni Cerro
Gli studi sul razzismo italiano non hanno una lunga storia alle spalle. Nonostante gli esordi più che promettenti (penso, solo per citare due esempi, alla mostra La menzogna della razza organizzata nel 1994 presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna dal Centro Furio Jesi e al volume Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia, […]

Gli studi sul razzismo italiano non hanno una lunga storia alle spalle. Nonostante gli esordi più che promettenti (penso, solo per citare due esempi, alla mostra La menzogna della razza organizzata nel 1994 presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna dal Centro Furio Jesi e al volume Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia, 1870-1945, apparso per Il Mulino nel 1999 a cura di Alberto Burgio), le ricerche si sono orientate quasi esclusivamente sull’esperienza fascista, scelta del resto comprensibile e quasi inevitabile, dedicando un’attenzione limitata ai molteplici fermenti che hanno attraversato l’età liberale e trascurando quasi del tutto la modernità.
Merita pertanto di essere accolta con favore la pubblicazione del libro La pensée de la race en Italie. Du romantisme au fascisme, a cura di Aurélien Aramini e Elena Bovo (Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2018, pagine 278, euro 20), che raccoglie saggi di studiosi francesi e italiani a confronto con un vasto corpus di fonti e testi relativi a molteplici campi del sapere, dalla filologia all’antropologia, dalla sociologia alla letteratura, fino al diritto.
Pur nella diversità dei presupposti metodologici adottati dai singoli autori, il punto di partenza comune dell’antologia è la distinzione tracciata da Pierre-André Taguieff tra racisme, ovvero l’insieme delle dottrine politico-scientifiche che implicano prescrizioni, che definiscono valori e norme e che si traducono in discriminazioni, segregazioni, espulsioni, persecuzioni fino a poter arrivare allo sterminio, e racialisme, cioè le elaborazioni ideologiche che hanno uno scopo anzitutto descrittivo ed esplicativo e che non sono direttamente animate da volontà discriminatorie.
La miscellanea riesce così a evitare il pericolo di una rilettura teleologica dei discorsi sulla razza prodotti nella seconda metà dell’Ottocento, che non vengono considerati in funzione delle politiche razziali del regime, ma come un oggetto di studio autonomo. Ciò consente di esplorare figure poco note a chi si occupa di razzismo, come quella, studiata da Aramini, dell’orientalista Gaspare Gorresio, titolare della prima cattedra universitaria di lingua e letteratura sanscrita in Italia e pioniere nella divulgazione dell’ideologia ariana nella penisola. A partire dall’idea che la filologia sia uno strumento attraverso il quale far emergere le credenze religiose, le convinzioni culturali e le concezioni politiche dei popoli del passato, Gorresio porta a compimento nell’arco di un trentennio, dal 1843 al 1870, una grandiosa impresa editoriale, finanziata dal governo piemontese: la pubblicazione del testo e della traduzione del poema epico indiano Rāmāyana, attribuito a Vālmīki. Nella prefazione al nono volume dell’opera Gorresio ripropone l’opposizione già presente in Ernest Renan, che aveva conosciuto durante i suoi studi a Parigi, tra spirito semitico e spirito indoeuropeo: la visione del mondo dei semiti, influenzata dalle religioni monoteistiche, deve limitarsi a rappresentare il dramma dell’eterna lotta dell’uomo con le sue passioni, mentre la superiore Weltanschauung degli ariani, con la ricca mitologia e la tendenza alla divinizzazione della natura, nonché grazie alla duttilità della lingua nella quale si esprime, è capace di elevarsi fino alle vette della lirica e dell’epopea. Gli europei del presente, degni eredi degli ariani d’Oriente, hanno conservato non solo questa spiccata tendenza alla spiritualità, ma anche la loro originaria forza espansiva e conquistatrice attraverso la quale possono trarre il massimo vantaggio dagli avanzamenti della scienza e della tecnica moderne. A conferma dell’importanza di Gorresio per la diffusione del mito ariano in Italia e al tempo stesso della sua capacità di intrattenere relazioni con gli studiosi europei del tema, in appendice all’antologia viene riportato uno scambio epistolare con Gobineau, che nel 1879 gli scrive per ottenere i tomi mancanti della sua «magnifica traduzione».
La raccolta fa luce anche su testi poco frequentati dalla storiografia, come L’uomo bianco e l’uomo di colore (1871) di Cesare Lombroso. Il libro, come nota Silvano Montaldo, ebbe un accidentato percorso che ne condizionò la fortuna e la circolazione. Frutto di una serie di conferenze di scienze popolari tenute presso l’Università di Pavia e terminato nel 1868, apparve soltanto tre anni più tardi per un piccolo editore padovano, Sacchetto; inoltre, proprio mentre Lombroso era impegnato nella correzione delle bozze, fu oscurato dall’uscita del darwiniano The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Combinando la teoria dell’evoluzione con considerazioni antropologiche e linguistiche (il libro è dedicato a Paolo Marzolo, «il Darwin dell’antropologia italiana») Lombroso intende spiegare la differenza e l’ineguaglianza tra le razze umane per capire «se noi bianchi, che torreggiamo orgogliosi sulla vetta della civiltà, dovremo un giorno chinare la fronte innanzi al muso prognato del negro ed alla gialla e terrea faccia del mongolo». Nello scritto, criteri estetici e giudizi di valore si intersecano fino a sovrapporsi e confondersi. Mentre all’europeo si riconoscono tutte le perfezioni fisiche e morali (il suo cranio spicca per «la stupenda armonia delle forme» e sulla sua fronte si staglia «la forza e il predominio del pensiero»), il «Negro» è considerato il parente più prossimo delle scimmie. La sua muscolatura e la struttura del suo scheletro sono, infatti, disseminate di caratteri pitecoidi e la diffusione delle ghiandole sudorifere conferisce alla sua pelle «quell’odore particolare che troppo ben sanno distinguere i cani negrieri»; intelligentissimo fino alla pubertà, da quel momento in poi il suo intelletto «s’arresta, e si ravvoltola in una scimiesca e stupida mobilità» al punto che «le passioni affogano l’intelligenza». Resistente alla febbre gialla e alla malaria, è insensibile al dolore. Al di sotto del «Negro», nella scala della natura tracciata da Lombroso, sta l’«Ottentotto», questo «Ornitorinco dell’umanità» che ha la sventura di assommare su di sé i tratti delle tribù africane e dei «chinesi», più quelli degli animali selvatici con cui vive a contatto. Le differenze tanto evidenti tra i vari gruppi umani, sostiene Lombroso, sono spiegabili non tanto con l’influenza dell’eredità, ma con quella modificatrice e trasformatrice del clima, secondo un’ipotesi che risale almeno a Montesquieu. Elementi vecchi e nuovi del razzismo europeo vengono così combinati in vista dell’esaltazione della superiorità dell’uomo bianco, il solo, si afferma nella conclusione, ad aver sviluppato arti degne di tal nome, ad aver affermato il principio di nazionalità e la libertà di pensiero, ad aver proclamato il rispetto per l’anziano, la donna e il bambino. Il solo che potrà perciò eternare le proprie idee nei monumenti e nei libri.
Un ulteriore merito della raccolta è l’approfondimento di immagini e stereotipi razziali sul lungo periodo, non solo quelli che circolano abbondantemente nel dibattito sulle «due Italie», ma anche quelli che riguardano tipi che potremmo definire regionali, come nel caso dei romagnoli, analizzato da Massimo Baioni. Il punto di partenza dell’analisi di Baioni è il saggio di Guglielmo Ferrero, futuro genero di Lombroso, I violenti e i frodolenti in Romagna pubblicato nel 1893. Nella prima parte dell’articolo, intitolata I fatti di Chiusa S. Michele e consacrata a un processo che aveva coinvolto repubblicani e socialisti, Ferrero distingue tra due forme di civiltà — quelle a tipo di violenza tipiche dei popoli primitivi, in cui prevale il ricorso alla forza, e quelle a tipo di frode, caratteristiche dei popoli moderni, in cui dominano l’astuzia e l’inganno — sostenendo che la Romagna è uno degli ultimi, residuali esempi in Europa delle prime. Ciò è dovuto alla scarsa differenziazione della società (manca qualsiasi coscienza di classe) e all’assenza pressoché totale nelle campagne e nelle città di una vera borghesia che sappia diffondere i propri codici di comportamento. In generale, negli atteggiamenti della popolazione sia rurale sia urbana si coglie una «fiera animalità primitiva», dedita alla libera espressione dei bisogni più elementari: appetito vorace, linguaggio a dir poco colorito, maniere brusche. Ne discende un’impulsività fuori controllo e un temperamento passionale che si riflettono anche nella vita politica, caratterizzate da contrasti simili a quelli che attraversavano l’Italia comunale nell’età di mezzo: l’omicidio è considerato uno strumento di lotta comune contro gli avversari, le questioni private si tramutano facilmente in questioni pubbliche e viceversa, i partiti non sono sodalizi di idee e di interessi condivisi, ma associazioni rette da irresistibili vincoli di fedeltà tra coloro che ne fanno parte. Quella di Ferrero è una visione non deterministica del carattere romagnolo, anzi talvolta indulgente verso di esso. Tuttavia, consolida o inventa stereotipi destinati a essere riproposti anche nei decenni successivi, come accade nei romanzi del forlivese Antonio Beltramelli (autore anche di una biografia mussoliniana), Gli uomini rossi (1904) e Il cavalier Mostardo (1922), o nell’interpretazione razziale della Romagna fornita dal giornalista di Cervia Rino Alessi nel numero speciale con il quale l’«Illustrazione italiana» rende omaggio nel settembre 1938 alla «terra del Duce». Queste riprese, tra continuità e rottura, mostrano come i numerosi razzismi che si fronteggiano negli anni del regime non siano l’invenzione di un giorno, ma si inseriscano in una lunga e fiorente linea di pensiero, la cui storia deve essere ancora in gran parte studiata e scritta.
di Giovanni Cerro